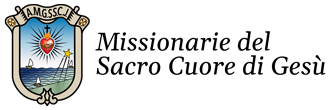di LUCIA CAPUZZI
Donne che vanno oltre. Così, parafrasando Madeleine Delbrêl, possiamo definire le missionarie.
Quelle che partono verso orizzonti lontani e luoghi remoti in cui vivono e, spesso, muoiono da martiri, nel senso di testimoni. E quelle che, «senza battello», oltrepassano frontiere culturali, sociali e spirituali per raggiungere l’altro. Come ci ricorda papa Francesco nel messaggio per la scorsa Giornata missionaria mondiale: «La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, la missione sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo».
Non è possibile tracciare un identikit rigido delle missionarie poiché la parola “missione” ingloba un contenuto plurale, multidimensionale, policromo. Fino alla seconda metà del Novecento, il termine veniva impiegato, in base all’accezione conferitale dai gesuiti nel XVI secolo, per indicare delle attività speciali della Chiesa. Nel boom missionario dell’Ottocento, si riferisce alla figura un po’ romantica del presbitero inviato ufficialmente dalla gerarchia ecclesiastica in un Paese non cristiano con il mandato di convertire la popolazione e edificare una comunità ecclesiale.
Una formula che, paradossalmente, esclude le donne. Eppure, proprio questo periodo, vede il fiorire di straordinarie figure: le grandi suore missionarie, da Francesca Saverio Cabrini, apostola dei migranti, a Laura Montoya, pioniera della difesa degli indigeni amazzonici. Donne che sono andate oltre in molti sensi, inclusi i pregiudizi nei propri confronti.
È il primo gennaio 1872 quando tre ragazze, Maria Caspio, Luigia Zago e Isabella Zadrich, danno vita al nucleo originario di quello che poi sarà il primo Istituto femminile esclusivamente missionario nato in Italia: le Pie madri della Nigrizia, ora comboniane. Il fondatore, Daniele Comboni, è consapevole dell’audacia della scelta e delle perplessità che rischiava di suscitare. A farlo perseverare è la convinzione profonda della necessità delle donne, testimoni della compassione di Dio per i poveri. Per questo, paragona le “sue” suore a «un sacerdote e più di un prete». Esse sono – scrive – «una vera immagine delle antiche donne del Vangelo, che, con la stessa facilità con la quale insegnano l’abc agli orfani abbandonati in Europa, affrontano mesi di lunghi viaggi a 60 gradi, attraversano deserti su cammelli, e cavalcano cavalli, dormono all’aperto, sotto un albero o in un angolo di una barca araba, aiutano i malati e chiedono giustizia dai Pascià per gl’infelici e gli oppressi. Loro non temono il ruggito del leone, affrontano tutti i lavori, viaggi disastrosi e la morte, per conquistare le anime per la Chiesa».
Altri istituti verranno costituiti negli anni immediatamente successivi: le suore saveriane, le suore della Consolata, le missionarie dell’Immacolata.
A mandare in crisi il concetto “classico” di missione e di missionario o missionaria è la sua associazione all’espansione coloniale dell’Occidente. Una certa narrativa cerca di integrare la trasmissione della fede nell’opera “civilizzatrice dell’uomo bianco” nei confronti di popoli “primitivi o selvaggi”. È il concilio Vaticano II a fare piazza pulita di ogni ambiguità e a dare uno spessore inedito all’impulso missionario. La missione non è uno dei tanti uffici ecclesiali bensì dimensione costitutiva della Chiesa che partecipa alla missio Dei. In tale ottica, si configura come un dinamismo il cui fine è raggiungere il mondo intero per trasformarlo in Popolo di Dio. Quest’ultimo è missionario poiché Dio lo è. Nell’ecclesiologia odierna, la Chiesa è considerata essenzialmente missionaria: esiste mentre è inviata e mentre si costituisce in vista della sua missione. Una svolta ben descritta nell’articolo della storica Raffaella Perin [a pag. 12]. Evangelii gaudium, ispirato dal documento di Aparecida e dagli stimoli del Sinodo sulla Nuova evangelizzazione, riprende con forza questa prospettiva. Nella “Chiesa in uscita” di cui parla papa Francesco, stile, attività, orari, linguaggio e struttura sono trasformati dalla scelta missionaria, che ne costituisce il perno. La riforma della Curia romana, contenuta nella Costituzione apostolica Praedicate evangelium, ne è l’incarnazione concreta, come illustrato dalla canonista Donata Horak [a pag. 18].
Essere missionari è, dunque, un modo di essere comunità ecclesiale. Non è sociologia. La missione non è una Ong, come ripete il Pontefice. Non è, cioè, un’attività istituzionalizzata, una funzione da svolgere, un impegno da portare a termine, seppure a fini benefici e caritativi. È la natura della Chiesa. Il motore del suo agire. Riguarda il cuore del Vangelo: inquietudine per chi è escluso e passione per il Regno. Come afferma Agostino Rigon, direttore generale del Festival della missione: «Se Dio si preoccupa del mondo interno, anche il campo della missio Dei è il mondo intero: ogni essere umano e tutti gli aspetti della sua esistenza».
È la fraternità a spingere l’uomo o la donna a farsi prossimo dei caduti agli angoli delle vie, ovunque essi si trovino: indigeni espulsi dalle loro terre, vittime di tratta, bimbi schiavi, rom intrappolati nelle periferie delle città, migranti condannati a un invisibile pellegrinare. Ad aiutarli a rialzarsi e ad accettare di essere rialzato da loro. Perché gli scartati sono maestri, di vita e di fede, come mette in luce un inedito progetto del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale che ha realizzato una sorta di “cattedra dei poveri di teologia”. Un gruppo di esperti ha rivolto le grandi domande della teologia a un gruppo di marginali fra i marginali. Le risposte, un distillato di Vangelo.
Da ciò, però, sorge un interrogativo cruciale. Se tutti i battezzati e le battezzate sono necessariamente missionari, ha ancora senso la scelta di quanti – laici e religiosi – lasciano il proprio Paese e si recano in luoghi lontani per annunciare il Vangelo con la vita e con le opere? «Ovviamente sono convinta di sì», afferma Marta Pettenazzo, religiosa delle missionarie di Nostra Signora degli Apostoli e prima donna a guidare tra il 2014 e il 2019 la Conferenza degli istituti missionari italiani (CIMI). «L’impegno missionario riguarda ciascuno e ciascuna. Alcuni e alcune, tuttavia, hanno la chiamata dedicare tutta la loro esistenza e talenti alla testimonianza del Vangelo, dentro e fuori dal proprio Paese». Una missione, dunque, intesa a trecentosessanta gradi e rivolta alla fragilità umana ovunque essa si trovi. Se l’orizzonte geografico non è più dominante, esso, tuttavia, non è scomparso.
«La cosiddetta missio ad extra, cioè vissuta in altre nazioni rispetto alla propria, è una delle dimensioni della missione e continua ad essere la priorità per alcuni Istituti o congregazioni. Al cuore di questa scelta non si colloca tanto lo spostamento fisico quanto l’attitudine esistenziale che implica la disponibilità a partire. Significa lasciare il tuo noto per andare verso qualcos’altro. E quando lo fai, ti metti necessariamente nell’attitudine dell’imparare. La missione mi ha insegnato che doni solo nel modo in cui in cui impari», sottolinea suor Marta.
Di nuovo, spunta la dimensione “dell’andare oltre” in cui il contributo delle donne diventa fondamentale. Lo è sempre stato: la prima missionaria della storia della cristianità è Maddalena, come ci racconta la biblista Marinella Perroni [a pag. 16]. La missione contemporanea, al cui cuore si collocano il prendersi cura e l’accompagnare, ha però un volto molto femminile, come dimostra il caleidoscopio di storie raccolte in questo numero. Da quella di Lisa Clark, missionaria della nonviolenza nella società civile e all’interno delle istituzioni, alla vicenda di suor Zvonka Mikec, dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, una vita missionaria in Africa, incontrata a Roma dalla scrittrice Tea Ranno, ex allieva delle salesiane. Il recupero del femminile, associato a lungo a irrazionalità e incapacità di gestione, come sostiene il teologo protestante David Bosch, è fondamentale per liberare il concetto di missione da ogni pretesa di dominio, da ogni ansia performativa, da ogni paradigma efficientista. Solo il missionario che al vigore abbina la tenerezza sa creare spazi di autentica gratuità.
Certo, tale atteggiamento mentale e spirituale richiede un percorso di formazione integrale che resta una delle sfide aperte. Istituti e congregazioni, per le religiose e/o le laiche che vi appartengono, sempre più abbinano alla teologia di base studi avanzati di missionologia, oltre a un curriculum specifico per la mansione che andranno a svolgere nelle diverse opere, dalla sanità all’istruzione. «Certo, andrebbe potenziata maggiormente la parte sull’interculturalità», dice suor Marta. Per quante, invece, scelgono di partire con associazioni o attraverso la diocesi, oltre alla formazione interna, esistono dei corsi specifici, tra cui quello del Centro unitario per la formazione missionaria (CUM) di Verona.
La nota dolente, specie in tempi di recessione mondiale, resta il sostentamento. Solidarietà e opere sono le prime fonti anche se perennemente insufficienti. Spesso il contributo dei benefattori copre la realizzazione di progetti specifici. Più difficile, però, trovare fondi per il mantenimento, indispensabile affinché le missionarie possano dedicarsi a tempo pieno agli ultimi. Religiose e laiche spesso optano per l’inserimento nelle diocesi dei Paesi di accoglienza. Rimane, tuttavia, da risolvere la questione di rendere il contributo riconosciuto per il loro impegno nella pastorale, pienamente adeguato rispetto al lavoro svolto e idoneo a sostenersi. Una modalità, ancora pionieristica, che si va affermando è quella di comunità missionarie intercongregazionali e, a volte, miste, che consentano di sperimentare appieno relazioni di reciprocità tra i generi.
Insomma, la missione del XXI secolo non può fare a meno delle donne. «La loro creatività è indispensabile per affrontare le situazioni limite nelle quali sei immersa in missione. Per me missionaria è colei che contribuisce a partorire la fede sia in chi non la conosce sia in quanti hanno perso il senso». Una “levatrice del Vangelo” che non ha l’ansia di battezzare o, peggio, di conquistare proseliti bensì cerca di aprire finestre per far entrare il soffio dello Spirito nelle donne e negli uomini di questo tempo.